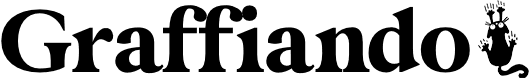Alla prima dell’opera più celebre di Ruggero Leoncavallo, che ha inaugurato la stagione autunnale del teatro Verdi, applausi per il baritono Ernesto Petti e la regia di Sarah Schinasi. Diverse le perle nere in buca, ma menzione per celli e bassi e un Daniel Oren concentrato a tener dialogo e collante, con alterna fortuna, tra palcoscenico e golfo mistico
di OLGA CHIEFFI
Pagliacci, Circus, Clown termine che viene dal latino colonus, in origine lo zòtico tonto, il contadino incolto o, comunque buffo e sottoposto ad ogni tipo di beffa, anche se beffatore lui stesso. Il titolo di Ruggero Leoncavallo ha inaugurato l’autunno del Teatro Verdi di Salerno venerdì sera. Sul podio Daniel Oren, alla testa di un’Orchestra Filarmonica “G.Verdi”, unitamente al coro e alle voci bianche preparati rispettivamente da Francesco Aliberti e Silvana Noschese, che ha inteso “fare”, una generale fiume, per concertare un’opera non facile, come si crede, poiché Daniel Oren ha, come tutti noi, un’ idea propria di questa partitura in testa, essendo un uomo che condivide la vita con la musica. Pagliacci è un’opera che sembra uscita forse dalle labbra infiammate di un Mangiafuoco di strada, da mascheroni imbiancati dalle enormi bocche che mettono paura, rievocanti sogni e mostri.
Una lingua incandescente quella di Oren, che avrebbe inteso creare certo amalgama in orchestra per passare dalle finezze salottiere del secondo atto, sino alla realizzazione di quell’oceano torbido, ove si devono intravvedere paurosamente limpidi i sentimenti dei mostri della profondità, i loro movimenti, i loro delitti, quelle strette impure di Tonio e di Canio. Menzione per violoncelli e bassi due splendide file, che a quest’opera hanno donato senso e luce, unitamente all’affidabilità dei flauti, nel loro centenario continuum, che ha permesso alla seconda parte, Mario Montani, di festeggiare i suoi venticinque anni in buca. Per il resto, ad ogni sezione la sua pecca: è sembrato che a volte il solfeggio e l’intonazione siano riusciti a mangiare se stessi, a cominciare dal primo oboe, una responsabilità altissima la sua, quella di essere alla testa dei legni e di offrire la nota d’intonazione all’intera orchestra, che ha reso fluttuante in diversi punti, in aggiunta alla grave disattenzione di un attacco, all’ inizio dell’opera, che ha costretto il Maestro Oren a riprendere la battuta, finale poco pulito per l’intera sezione degli ottoni, con bel suono della tromba di palcoscenico, anche se l’emozione le ha tirato via una stecca, mentre perfetto l’ oboe ciaramellante per l’arrivo degli zampognari. Un racconto non facile da decifrare quello di Pagliacci, che resta un’opera di passaggio ancora divisa tra certi echi romantici e la mira di voler andare decisamente oltre. Jorge de Leon ha dipinto un Canio perfetto ma solo a partire dal bis di “Vesti la giubba” pronunciato in un crescendo di cupezza, dagli accenti roventi e terribili, bella proiezione e recitazione, in uno specchio che diventa passaporta per attraversare la quarta parete, passaggio alla realtà. Canio attraversa di continuo lo specchio che divide nettamente i due luoghi.
E’ giusto quello stesso specchio attraverso cui Dioniso guardò e vide la realtà, prendendo coscienza di sé, conoscendosi e facendosi conoscere, lo specchio deformante del mondo. Mai parlare di metateatro con Pagliacci, pensando a Pirandello: per lo scrittore è la crisi dell’identità dell’uomo che non riesce a vivere se non fingendosi una parte, recitandola, mentre Canio decide di gettare la maschera, pur nel delirio. Se la Nino Machaidze è una Nedda con buona voce, spigliata nella recitazione, ma assente nello scavo della parola, quindi della pronuncia, la rivelazione è Ernesto Petti, che ha giocato in casa, ha fatto vivere la figura di Tonio, esaltata sicuramente nel canto, applauditissimo, sin dal prologo, il quale ha, però, poco delineato il suo ruolo oscuro, pur cantando con precisione e fraseggio raffinato, registri omogenei e squillo potente degli acuti. C’è sempre un momento in cui ci si chiede: e se Tonio non fosse deforme? Un toccato dalla natura? La deformità di Tonio deve soprattutto rinviare al mondo sociale in cui egli agisce, un mondo di guitti, che recitano parti assurde per non vedere la realtà e quando essa arriva, non possono che continuare a fingere, per non riconoscere il proprio squallore e quel nero, il livore, la gelosia e la bestemmia contro la natura che lo ha condannato ad essere clown, non si è toccato con mano.
La Schinasi ha usato la luce come non voleva Bruno Barilli, che scriveva: “La luce, elemento prezioso, vuol essere propinata avaramente come un filtro. Il palcoscenico non è che un pozzo nero e profondo da esplorare con la lanterna cieca, e se il macchinista apre tutte le valvole dell’elettricità, diventa un buco enorme e deserto, uno spogliatoio miserabile(…)In un palcoscenico pieno d’ombra e di mistero i personaggi, questi prigionieri del melodramma che tentano di liberarsi contorcendosi michelangiolescamente (…)investirà con un riverbero pieno di fermento le loro facce stravolte, frantumandosi come una bottiglia di vetriolo”. Dopo l’intermezzo, con Nedda, che sa con chiarezza che la fiamma nel guardo del consorte non aveva speranza di spegnersi, se non con la sua dipartita, non è stata sottolineata da una regia che è rimasta un po’ schiava della scrittura musicale leggera di Leoncavallo, ovvero la Serenata, ben eseguita e adeguatamente al segno di Leoncavallo timbrata da Francesco Pittari, e dal duetto amoroso Nedda-Silvio, con quest’ ultimo interpretato da Tommaso Barea, che come nella Cenerentola salernitana, in cui fu un incerto Alidoro, anche nel ruolo di Silvio si è confermato tale. Marionette ritrovate negli abiti, il tutù della Colombina di sostegno a Nedda e dell’Arlecchino-Beppe di Francesco Pittari riutilizzati in più produzioni, come l’idea delle maschere della commedia dell’arte, in quadro o in carillon. Il circus ha ricordato quello creato per la Fille du Regiment da Flavio Arbetti e Riccardo Canessa, che con casse e pannelli e mascherone in fondo, costruirono un vero e proprio salotto, di estrema raffinatezza, ma il climax di Pagliacci è nettamente diverso. Qualche discromia nel coro preparato da Francesco Aliberti, mentre siamo al ricambio per le voci bianche di Silvana Noschese, che hanno iniziato bene il loro percorso. Applausi e rose come d’abitudine, per tutti.
Fotografie di Pasquale Auricchio