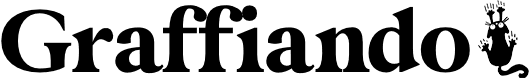All’Opera di Roma la bacchetta di Mariotti non fa miracoli in Puccini, ma trionfa con la partitura di Luigi Dallapiccola, così come la regia di Calixto Beito la cui discriminante è giardino della ri-nascita per entrambi i drammi, convince per il secondo titolo. Sugli scudi i due protagonisti Yolanda Auyanet e Mattia Olivieri. Bene il coro diretto da Ciro Visco e i comprimari di scuola salernitana Ilaria Sicignano e Nicola Straniero
Sigillo finale per il “Trittico ricomposto” all’ Opera di Roma, la cui ultima replica ha condotto ad inaugurare il mese di maggio con “Suor Angelica” di Giacomo Puccini, finale delle celebrazioni del centenario per il progetto realizzato con la direzione (pre-golpe) del Festival Puccini di Torre del Lago, in dittico con “Il prigioniero” di Luigi Dallapiccola, in occasione del cinquantenario della scomparsa. In una Roma silente, riflettente il lutto profondo dell’intera cristianità, per una strana, quasi miracolosa coincidenza è andata in scena l’essenza del Puccini sacro, “Suor Angelica”, affidata al regista Calixto Beito e alla bacchetta di Michele Mariotti. Il regista ha idealizzato il giardino, quale kèpos, recinto di morte e rinascita, Paradiso, dove non si può mentire, poiché il simbolo non perde mai quell’origine antichissima che lo identifica nella semantica come intimo mistero, anche oscuro. Giardino che dà morte liberatoria alla sua “potnia”, Suor Angelica, giardino che diventa prima simbolo di libertà per il Prigioniero, quindi tomba, spenta ogni illusione in terra, quando si avvia con passo sicuro verso l’ Oltre. Simbologia letta, quella del regista che fa quasi intuire tra le righe anche un internato psichiatrico, con suore disabili, depresse, “melanconiche”, alienate dall’aborto, volte al peccato di gola, al desiderio maturato quando vivevano ancora in società. Anche il Prigioniero attraversa la scena, legando il tutto alla partitura successiva, portato come ferito o addirittura come Cristo morto, lo vediamo cogliere un frutto, un pomodoro, una primizia per il periodo invernale in cui si svolge l’opera (una novizia?), mentre la zia Principessa non si presenta in nero con tanto di bastone, anticipatrice di Turandot, ma in fantasia fiorata e portadocumenti in cuoio pur facendo scattare il diabolus in musica, il tritono simbolo del barone Scarpia, restando “bigotta satira” come non mai della medio-alta borghesia rampante, “arriffabile” per dirla nella lingua napoletana, che ha da sposare la nipote, nonostante la grave macchia del figlio spurio (fortunatamente morto) di Suor Angelica. Desiderio di tutte le suore, incluso della Zia Principessa, è il ritorno alla terra, spogliandosi degli abiti, come poi si denuderà anche il prigioniero per farsi lavare (acqua lustrale) dalla madre, siamo alla soglia del senza suono. Il ritorno alla terra è comunque gioioso. Si acquista gioia a cominciare dalla fine. Ora ancor meglio tocca come la fine, per ogni cosa, sia subito negli inizi, che sono gioia, che hanno perduto la gioia. Ma l’uomo che ha perduto la gioia, che è così pronto a perderla in ogni sua impresa ed evento , come è un uomo della fine – un uomo da sempre e per sempre moderno, chè la religione della modernità arriva quando la gioia ha fine, cioè subito, bruciando tempo e vicenda od evento – è uomo appena iniziato, appena creato. Un uomo primordiale, uomo dell’inizio: il segreto bambino. Michele Mariotti non è riuscito a trasmettere emozione attraverso la sua lettura asciutta, priva di quell’abbandono, anche patetico, che pur è necessario, con una prima parte di Suor Angelica che, fatto salvi le percussioni e legni, ha offerto anche un’orchestra tra discromie e discronie, svanite con l’arrivo della Zia Principessa. Suor Angelica delira tra disperazione per il peccato mortale del suicidio e la crisi mistica nel suo abbagliante “venir meno” di dantesca memoria, ma il miracolo della musica non avviene, non si avverte, al di là del coro interno diretto da Ciro Visco “ O gloriosa Virginum, sublimis inter sidera”, nello sfavillio dei due pianoforti, dell’organo, del glockenspiel e della celesta, nell’indovinata intensità sonora, del , maestro napoletano, con Suor Angelica in terra senza apparizioni, nell’attuazione delle risposte del Cartilo, del Fedone e del Somnium Scipionis. Nel ruolo del titolo ha debuttato Yolanda Auyane, Do acuti non inappuntabili, quello de’ la “Vergine santa” leggermente calante, ma ha rivelato buoni numeri anche se non esaltata dal contesto generale, morbida nei centri, nelle mezze voci, come nel legato. La Zia Principessa, è stata interpretata da Marie-Nicole Lemieux, timbro smaltato, gravi affatto pieni, con acuti con buoni omogeneità di emissione, ma non si è opposta con tetraggine alla luminosità di Angelica. Bene la Badessa di Annunziata Vestri, come anche la Suora Zelatrice di Irene Savignano, con loro le voci aggraziate, de’ la Maestra delle Novizie, Carlotta Vichi, Suor Genovieffa, Laura Cherici, Suor Osmina e la novizia, Jessica Ricci. Perfetta e indovinata teatralmente la Suor Dolcina di Ilaria Sicignano, la quale ha iniziato gli studi nel conservatorio G.Martucci di Salerno, la quale ha brillato per freschezza e spontaneità. A completare il cast la Suora Infermiera, Maria Elena Pepi, le due cercatrici Marianna Mappa e Claudia Farneti e le due converse Sofia Barbashova e Caterina D’Angelo. Il linguaggio di Luigi Dallapiccola, fondato sull’impiego di serie dodecafoniche temperate dalla presenza di centri d’attrazione dei suoni, in cui confluiscono le esperienze d’oltre un decennio, anzi di una vita continuamente segnata dal dramma della libertà contesa, della sua perdita , della sua incessante ricerca e riaffermazione, gli eventi storici dell’epoca, vissuti con intensa partecipazione, insieme ad impressioni d’infanzia e suggerimenti letterari, ha perfettamente vestito la bacchetta di Michele Mariotti, che qui ha avuto la sua punta di diamante sia nell’orchestra la quale ha risposto in pieno alla sua concertazione, sia nella voce e nell’interpretazione del baritono Mattia Olivieri, dal timbro vellutato e la potenza di una “Ferrari” (il cantante è di Maranello), il quale ha sorpreso per la calzante adesione al personaggio, nei suoi vari momenti psicologici. Una linea di canto sicura e con buone sfumature, che il baritono ha, tra l’altro, dovuto svolgere, in labile equilibrio, raggomitolato su di un tronco secco. La sua voce ha descritto nell’essenza i cambiamenti d’animo di chi si sente perduto, per poi riaccendersi di una speranza costruita intorno a una parola chiave “Fratello”, che il carceriere gli ripete, consapevole dell’effetto torturatore che essa assumerà al momento della fine, già determinata. E’ la lenta agonia del condannato a morte, che affida l’ultima speranza alla fuga, intesa anche quale evasione da concetti opposti, quali che si sovrappongono, si identificano, si annullano, quali libertà e prigionia, speranza e supplica, la madre e la campana di Gand, il fratello come Carceriere e Grande Inquisitore, l’espiazione e la redenzione, la grazia e la tortura, la preghiera e la bestemmia, conclusa nell’abbraccio gelido del suo carnefice: «Alla vigilia della tua salvezza, perché mai ci volevi abbandonare?» cui prima della stretta mortale risponde: «La libertà?» Con lui Ángeles Blancas nella parte della Madre, protagonista nel Prologo, dallo strumento ampio e sontuoso, con timbro screziato accanto al figlio nella prima scena, ma praticamente sempre in palcoscenico. Per il ruolo del Carceriere e del Grande Inquisitore il tenore John Daszak, un po’ a disagio nei pericolosi falsetti, ma teatralmente valido. A completare il cast, nei panni del Primo Sacerdote il tenore Nicola Straniero, tenore in carriera, di scuola salernitana, diplomatosi alla Fabbrica dell’Opera di Roma, dopo aver lavorato nel coro della Scala, il quale ha offerto il suo breve intervento con voce ben centrata, parimenti all’altro sacerdote, il baritono Arturo Espinosa. Contraddizioni per la regia e tradimenti come quello del libretto che vuole un palcoscenico avvolto nell’ombra, mentre la cella sin dalle prime scene è stata investita dal rettangolo di luce accecante proveniente dal giardino sollevato, quasi ad immaginare un ring, come pure certo la corsa per il palcoscenico non renderà mai in modo soddisfacente il lungo episodio dell’evasione attraverso l’interminabile corridoio dell’Official di Saragozza. Ciò non si ottiene con un prigioniero, allo stremo delle forze, che va e viene per la scena, guizza e balza vivace. Ma l’opera, la musica, si è imposta in tutta la sua classicità ugualmente, con il suo passaggio dalla realtà dell’esperienza vissuta alla rappresentazione fantastica, dal “fondo” per dirla con Valèry, alla “forma”.