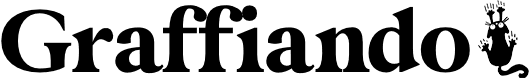Il maestro Francesco Rosa non ci è parso divertirsi sul podio, staccando a volte tempi soporiferi, del teatro Verdi, che ha inteso ri-presentare la celebre operetta di Franz Lehar, come ci son riusciti, invece, i ballerini e una Marisa Laurito nei panni del Njegus, la quale non ha disdegnato di prodursi in una perfetta spaccata
di OLGA CHIEFFI
Non si esce, oramai, da decenni dalla gabbia dorata della Vedova Allegra, in salsa napoletana, qui al teatro Verdi di Salerno. Il gioco con i nostri doppi-sensi, la macchietta, la superstizione che, stavolta, hanno lasciato intravvedere addirittura San Matteo e Pontecagnano, nei dialoghi comici tra la signorina Njegus, alla quale ha dato corpo e voce Marisa Laurito e il Barone Mirko Zeta, interpretato da un Filippo Morace che ha vestito perfettamente la livrea del diplomatico pontevedrino. Sfarzo e gusto floreale, nelle scene realizzate da Alfredo Troisi, con i costumi già notati e applauditi per la Vedova all’aperto del teatro Ghirelli, un balletto vispo e bello, ha segnato il rush finale della stagione lirica, infiammando il teatro.
Dinanzi ad un massimo cittadino stipato, in ogni ordine di posto, si è levato il sipario sugli stucchi e gli ori del salotto dell’ambasciatore del Pontevedro a Parigi che, sembravano la giusta continuazione dell’interno del nostro massimo: l’epoca è la stessa, una Parigi fin de siecle, con uno spruzzo di Napoli, donata dalla scoppiettante Marisa Laurito, nei panni della cancelliera d’Ambasciata Njegus, organizzatrice di festini, schizzante “una napoletana a Parigi”, dall’inventiva comica, che non ha disdegnato di evocare simpaticamente quel periodo buio, del genere, affidato alle compagnie di “giro”, durante il quale si diceva che i testi originali non tenevano più e che bisognava cambiarli, fin dove possibile. Spazio ritagliato per Marisa da Riccardo Canessa, che è riuscito nella sua opera di controllo della leonessa da palcoscenico, che non si è fatta indietro nel prodursi anche in una perfetta “spaccata”, con il numero “Stanotte faccio il Parigin”, adattata al femminile per lei, proprio da Gino Landi, che qui a Salerno, firmò un’indimenticabile Vedova Allegra, con un balletto e quattro numeri di can-can finale sopra le righe. In questa tanz-operetta, il balletto, è riuscito ad esprimersi in tutto il suo fulgore, nell’apertura del secondo atto, in occasione della festa patriottica nel giardino di Anna Glavari, intrisa di sonorità tzigane e nel Can Can che caratterizza il finale del terzo atto, affidato a Pina Testa, la quale ha coreografato forze giovani, salernitane, una restaurazione dopo la parentesi della scorsa stagione che salutò la formazione di un corpo di ballo del nostro massimo e la produzione del Romeo e Giulietta di Sergeij Prokofiev con bel successo. Apprezzabili le voci a cui sono stati affidati i ruoli principali, tra cui Mihaela Marcu, una indovinata Hanna Glawari, convincente e fascinosa anche nel fisico, tutta riserbo, compostezza e buona tecnica, unita a doti di profonda intensità che hanno esaltato l’aria di “Vilia, o Vilia, ninfa del bosco”, una voce da baritono, quella del Conte Danilo Danilowitsch, un Enrico Marabelli, affogato negli acuti che ci ha fatto rimpiangere per pronuncia e fraseggio i preziosismi, sia nell’attacco di Venite orsù sirene della danza, che nel duetto celeberrimo “Tace il labbro”, del tenore Salvatore Minopoli, in un’opera che ha da brillare di gioventù e freschezza e per recitazione, sotto e sopra il palcoscenico. Dignitosa sia la voce che l’interpretazione di Francesco Castoro, il quale ha vestito i panni dei Camillo De Rosillon, che ha ben figurato nel duetto con Valencienne, bella conoscenza la Nina Solodovnikova, già apprezzata nella Vedova dello scorso anno, nella decima scena del II atto. Alti e bassi tra gli altri interpetri che in palcoscenico attorialmente hanno dato una qualche idea di “fissità”, a cominciare da Francesca Micarelli (Sylviane), Antonio Cappetta (Bogdanowitsch), Sara Vicinanza (Praskovia) e Vittorio Di Pietro (Pritsctsch), mentre nel mood creato da Canessa, si sono perfettamente calati Christian D’Aquino (Kromow) e Valeria Padovano (Olga) i quali hanno recitato con accento russo e Vincenzo Tremante (Raul De Saint Brioche) che ha avuto ordine dal regista di lasciare la Hanna tra le braccia di Danilo, evocando il suo famoso zio Don Antonio Papale, nobile napoletano, contrario al matrimonio, con la “r” moscia. Amalgama perfetto, stavolta, tra flauti e oboe e i restanti legni per l’orchestra diretta da Francesco Rosa, il quale ha purtroppo appiattito un po’ tutto, colori e tempi, dominato da una partitura che sappiamo non facile, ma per la quale bisogna pur alzar le “armi” per poter concedersi con “brio”, comminando, in questa produzione, malaguratamente, diverse diacronie con i cantanti nei pezzi d’assieme, pur considerando l’enorme difficoltà nel tenere a bada solisti, coro e ballerini. Studiosa scioltezza anche per il coro, diretto da un Francesco Aliberti, scatenato nei saluti finali e passerella con rose rosse, per tutti con il pubblico diretto nell’applauso di accompagnamento al finale con il direttore in scena, insieme a Riccardo Canessa e tutti gli artisti e l’orchestra in buca, finalmente libera di scegliere i tempi adatti alle bollicine di Chez Maxime, certamente quelle dell’Armand de Brignac millesimato, per sostenere il tourbillon finale, idoli di un uditorio, che ama da sempre perdersi in queste evasioni del bel mondo, di questa nobiltà estenuata e debilitata e della sua idolatria del denaro, danzante su di un pavimento marcio che di lì a poco sarebbe irrimediabilmente crollato.